
Parte seconda
Nello scrivere si evidenzia una cronaca colta e dettagliata: infatti, esaminare il mutamento di prospettiva intervenuto in lavori dello stesso autore scritti in periodi diversi permette di comprendere meglio i problemi connessi alla questione del «futuro del capitalismo»: ha «i secoli contati» oppure è in atto una transizione verso il post-capitalismo, magari verso qualche forma di socialismo? Non c’è dubbio che il riferimento alle categorie analitiche marxiane sia essenziale per ragionare sulla questione. I monumentali libri di Piketty, 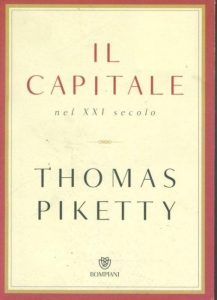 divisi da tempi più lunghi rispetto alle date di edizione (le ricerche per il primo cominciano nel 1998), sono la punta teorica più evidente di questo itinerario, ma non sono isolati da una temperie di pensamenti che percorre una parte della cultura lato senso liberale.
divisi da tempi più lunghi rispetto alle date di edizione (le ricerche per il primo cominciano nel 1998), sono la punta teorica più evidente di questo itinerario, ma non sono isolati da una temperie di pensamenti che percorre una parte della cultura lato senso liberale. 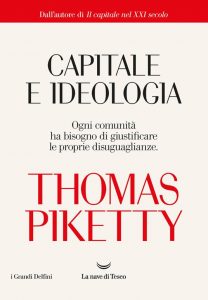 Di particolare interesse, ad esempio, il fatto che già a fine secolo si potesse leggere in un magazine americano di alto livello culturale, il «The New Yorker, frasi come questa: «His books [Il capitale] will be worth reading as long as capitalism endures». Sostenere che Il capitale meriterà di essere letto finché esisterà il capitalismo, potrebbe sembrare un’affermazione ovvia. In verità non lo è assolutamente neppure oggi, dopo un ventennio di crescita ininterrotta delle pubblicazioni dedicate a Marx ed al suo capolavoro. La frase citata appartiene [4] a John Cassidy ed è del 1997, periodo in cui le magnifiche sorti e progressive di un capitalismo liberato da lacci e lacciuoli condannavano Il capitale alla relegazione perpetua nel cimitero dei libri inusabili, dei libri morti. Un lungo articolo del 1997 sul «The New Yorker», in realtà un breve saggio, non è di particolare interesse solo per
Di particolare interesse, ad esempio, il fatto che già a fine secolo si potesse leggere in un magazine americano di alto livello culturale, il «The New Yorker, frasi come questa: «His books [Il capitale] will be worth reading as long as capitalism endures». Sostenere che Il capitale meriterà di essere letto finché esisterà il capitalismo, potrebbe sembrare un’affermazione ovvia. In verità non lo è assolutamente neppure oggi, dopo un ventennio di crescita ininterrotta delle pubblicazioni dedicate a Marx ed al suo capolavoro. La frase citata appartiene [4] a John Cassidy ed è del 1997, periodo in cui le magnifiche sorti e progressive di un capitalismo liberato da lacci e lacciuoli condannavano Il capitale alla relegazione perpetua nel cimitero dei libri inusabili, dei libri morti. Un lungo articolo del 1997 sul «The New Yorker», in realtà un breve saggio, non è di particolare interesse solo per  il momento in cui viene scritto, ma anche per il modo in cui viene delineato il percorso che ha portato Cassidy all’affermazione suddetta. Percorso che Cassidy
il momento in cui viene scritto, ma anche per il modo in cui viene delineato il percorso che ha portato Cassidy all’affermazione suddetta. Percorso che Cassidy  fa iniziare dalla riflessione suscitata dalle parole di un amico: «Più tempo spendo a Wall Street, più sono convinto che Marx avesse ragione», ha detto. Ho pensato che stesse scherzando. (…) Ha continuato, abbastanza seriamente. «Sono assolutamente convinto che l’approccio di Marx sia il modo migliore per guardare al capitalismo». C’è da restare stupiti. Stupore perché l’interlocutore amico e compagno d’università, «a higly intelligent and levelheaded Englishman», aveva occupato e occupava i ranghi più alti delle società di investimento
fa iniziare dalla riflessione suscitata dalle parole di un amico: «Più tempo spendo a Wall Street, più sono convinto che Marx avesse ragione», ha detto. Ho pensato che stesse scherzando. (…) Ha continuato, abbastanza seriamente. «Sono assolutamente convinto che l’approccio di Marx sia il modo migliore per guardare al capitalismo». C’è da restare stupiti. Stupore perché l’interlocutore amico e compagno d’università, «a higly intelligent and levelheaded Englishman», aveva occupato e occupava i ranghi più alti delle società di investimento 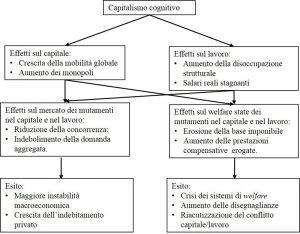 nella City di Londra e a Wall Street. Stupore perché il comune insegnamento oxoniense dei primi anni Ottanta, pure in gran parte ispirato a Keynes, considerava la teorica marxiana non degna dell’eccelso insegnamento di Oxford. Adatta (lo snobismo delle classi alte britanniche, quelle che hanno fatto le scuole giuste, non risparmia nemmeno i colti e gli intelligenti) «only for polytechnic lectures». Per lo «stupito» ascoltatore restava il fatto, però, che un «inglese estremamente intelligente ed equilibrato», che aveva studiato economia ad Oxford, e che, soprattutto, era ben inserito al centro del capitale finanziario mondiale, ritenesse l’approccio marxiano come la strada migliore alla comprensione dei meccanismi di funzionamento del modo di produzione capitalistico. E, dunque, «perhaps it was time to take a look». «Dare un’occhiata» è un evidente understatement; Cassidy si procurò, ovviamente, Il capitale e il Manifesto, ma anche l’Epistolario, le Teorie sul plusvalore,
nella City di Londra e a Wall Street. Stupore perché il comune insegnamento oxoniense dei primi anni Ottanta, pure in gran parte ispirato a Keynes, considerava la teorica marxiana non degna dell’eccelso insegnamento di Oxford. Adatta (lo snobismo delle classi alte britanniche, quelle che hanno fatto le scuole giuste, non risparmia nemmeno i colti e gli intelligenti) «only for polytechnic lectures». Per lo «stupito» ascoltatore restava il fatto, però, che un «inglese estremamente intelligente ed equilibrato», che aveva studiato economia ad Oxford, e che, soprattutto, era ben inserito al centro del capitale finanziario mondiale, ritenesse l’approccio marxiano come la strada migliore alla comprensione dei meccanismi di funzionamento del modo di produzione capitalistico. E, dunque, «perhaps it was time to take a look». «Dare un’occhiata» è un evidente understatement; Cassidy si procurò, ovviamente, Il capitale e il Manifesto, ma anche l’Epistolario, le Teorie sul plusvalore, 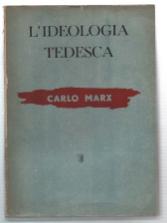 L’ideologia tedesca, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte. Lettura attenta dei testi ed insieme lettura di una realtà che già allora, per chi sapesse e volesse vedere, mostrava i segni delle tendenze che avrebbero caratterizzato il primo ventennio del nuovo secolo, portarono un giornalista con forte senso della deontologia professionale, a dire: «I gradually began to grasp what my friend had been talking about». Cassidy è uno di quei giornalisti anglosassoni che quando affrontano temi marxiani hanno ben presente il testo e la letteratura essenziale sul testo. Un modo di esercitare il mestiere in Italia pressoché sconosciuto nei grandi quotidiani e nei periodici d’opinione. Tra l’altro, pressoché nello stesso tempo, esce una biografia del pensatore di Treviri frutto del lavoro di un altro giornalista [5] Francis Wheen.
L’ideologia tedesca, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte. Lettura attenta dei testi ed insieme lettura di una realtà che già allora, per chi sapesse e volesse vedere, mostrava i segni delle tendenze che avrebbero caratterizzato il primo ventennio del nuovo secolo, portarono un giornalista con forte senso della deontologia professionale, a dire: «I gradually began to grasp what my friend had been talking about». Cassidy è uno di quei giornalisti anglosassoni che quando affrontano temi marxiani hanno ben presente il testo e la letteratura essenziale sul testo. Un modo di esercitare il mestiere in Italia pressoché sconosciuto nei grandi quotidiani e nei periodici d’opinione. Tra l’altro, pressoché nello stesso tempo, esce una biografia del pensatore di Treviri frutto del lavoro di un altro giornalista [5] Francis Wheen. 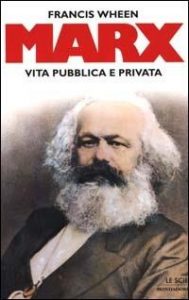 Anche in questo caso il rapporto dell’autore con testi marxiani è improntato a forte professionalità. Il fatto che un discorso critico sul capitalismo fosse possibile anche in anni di euforia neoliberista e che potesse partire da ambito liberale e giornalistico, nei Paesi anglosassoni è motivo di riflessione, in particolare per la Sinistra italiana, essendocene nel nostro Paese solo una debolissima traccia. Proseguendo: nella fase di accumulazione in corso «la questione della distribuzione delle ricchezze è (…) una delle più rilevanti dibattute»,
Anche in questo caso il rapporto dell’autore con testi marxiani è improntato a forte professionalità. Il fatto che un discorso critico sul capitalismo fosse possibile anche in anni di euforia neoliberista e che potesse partire da ambito liberale e giornalistico, nei Paesi anglosassoni è motivo di riflessione, in particolare per la Sinistra italiana, essendocene nel nostro Paese solo una debolissima traccia. Proseguendo: nella fase di accumulazione in corso «la questione della distribuzione delle ricchezze è (…) una delle più rilevanti dibattute»,  scrive Piketty, e «merita di essere studiata in maniera sistematica e metodica». I risultati della ricerca «sistematica e metodica» durata 15 anni (1998-2013. Nell’economia professionale: di Piketty, si sono concretizzati in un grosso volume di più di 900 pagine (tanto nell’edizione italiana che in quella francese) ed un rimando ad altro volume on line dedicato alle fonti ed alla loro discussione critica. Un’opera, si penserebbe, destinata ad una circolazione limitata tra specialisti e giornalisti economici; invece, è stata tradotta in 40 lingue ed a oggi ha venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie. Altro segno della centralità del problema delle disuguaglianze nella discussione sul presente e sul futuro del capitalismo. Non ci inganni il titolo, “Il capitale nel XXI secolo”, come è successo a quei pubblicisti che hanno chiamato Piketty il «Marx del XXI secolo». D’altra parte, egli dice chiaramente (allora) di essere «vaccinato a vita contro i discorsi anticapitalistici». Ed altrettanto chiaramente, in un’intervista del 2014 a «The New Repubblic», afferma di conoscere pochissimo Marx, di averne letto qualche saggio politico, ma «but not the economic work». E quanto a Il capitale, libro che «is very difficult to read», egli confessa che «never managed really to read it».
scrive Piketty, e «merita di essere studiata in maniera sistematica e metodica». I risultati della ricerca «sistematica e metodica» durata 15 anni (1998-2013. Nell’economia professionale: di Piketty, si sono concretizzati in un grosso volume di più di 900 pagine (tanto nell’edizione italiana che in quella francese) ed un rimando ad altro volume on line dedicato alle fonti ed alla loro discussione critica. Un’opera, si penserebbe, destinata ad una circolazione limitata tra specialisti e giornalisti economici; invece, è stata tradotta in 40 lingue ed a oggi ha venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie. Altro segno della centralità del problema delle disuguaglianze nella discussione sul presente e sul futuro del capitalismo. Non ci inganni il titolo, “Il capitale nel XXI secolo”, come è successo a quei pubblicisti che hanno chiamato Piketty il «Marx del XXI secolo». D’altra parte, egli dice chiaramente (allora) di essere «vaccinato a vita contro i discorsi anticapitalistici». Ed altrettanto chiaramente, in un’intervista del 2014 a «The New Repubblic», afferma di conoscere pochissimo Marx, di averne letto qualche saggio politico, ma «but not the economic work». E quanto a Il capitale, libro che «is very difficult to read», egli confessa che «never managed really to read it».  Nella lettura de Il capitale del XXI secolo si può facilmente verificare quanto ciò sia vero tutto. Gli scarsi riferimenti a Marx sono pressoché tutti prove evidenti di non lettura del testo, di riferimenti a letture, peraltro sbagliate, di seconda o di terza mano. Su questo piano le critiche al libro di Piketty sono certamente corrette. Il «capitale» per Piketty coincide sostanzialmente con la somma di tutte le componenti della ricchezza e niente ha a che vedere con quell’insieme di rapporti economico-sociali che è il «capitale» per Marx. Non si tratta di un libro sul «capitale», bensì sulla «distribuzione della ricchezza» in definite serie storiche. E sempre sullo stesso piano ha certamente ragione chi mette in evidenza che la scomparsa del concetto di «merce» dall’analisi di Piketty, «e soprattutto di quella particolare merce che è la forza di lavoro, trascina con sé in una oscurità indistinta le lacerazioni e le furiose contraddizioni che attraversano tutti i soggetti della vita economica e sociale». Appurato che Il capitale del XXI secolo non è un aggiornamento di quello di Marx e che è alieno da ispirazioni marxiste, è un fatto che proprio dai suoi recensori marxisti venga anche sottolineata, e con vigore, l’importanza di quel lavoro. Uno di questi
Nella lettura de Il capitale del XXI secolo si può facilmente verificare quanto ciò sia vero tutto. Gli scarsi riferimenti a Marx sono pressoché tutti prove evidenti di non lettura del testo, di riferimenti a letture, peraltro sbagliate, di seconda o di terza mano. Su questo piano le critiche al libro di Piketty sono certamente corrette. Il «capitale» per Piketty coincide sostanzialmente con la somma di tutte le componenti della ricchezza e niente ha a che vedere con quell’insieme di rapporti economico-sociali che è il «capitale» per Marx. Non si tratta di un libro sul «capitale», bensì sulla «distribuzione della ricchezza» in definite serie storiche. E sempre sullo stesso piano ha certamente ragione chi mette in evidenza che la scomparsa del concetto di «merce» dall’analisi di Piketty, «e soprattutto di quella particolare merce che è la forza di lavoro, trascina con sé in una oscurità indistinta le lacerazioni e le furiose contraddizioni che attraversano tutti i soggetti della vita economica e sociale». Appurato che Il capitale del XXI secolo non è un aggiornamento di quello di Marx e che è alieno da ispirazioni marxiste, è un fatto che proprio dai suoi recensori marxisti venga anche sottolineata, e con vigore, l’importanza di quel lavoro. Uno di questi  [6] Frédéric Lordon, proprio uno dei critici più severi, ha scritto: “Non c’è opinionista che non sia stato impressionato dall’enormità e dalla qualità del lavoro statistico. E noi siamo fra questi. Inoltre, si potrebbe affermare che la principale qualità del libro di Piketty sia da cercare altrove: è… un libro, ossia quel che gli economisti hanno radicalmente disimparato a fare, ossessionati dall’imperativo di pubblicare che impone loro di moltiplicare gli articoli tecnici e standardizzati, specialistici fino alla perdita di senso, vincolati alle quindici pagine imposte dalle riviste universitarie. Invece, Il Capitale del XXI secolo è la conclusione in mille pagine di uno sforzo perseguito ostinatamente per quindici anni. Infine, l’utilità delle scienze sociali diventa tanto più evidente quando queste si adoperano per nutrire il dibattito politico di fatti solidamente comprovati”.
[6] Frédéric Lordon, proprio uno dei critici più severi, ha scritto: “Non c’è opinionista che non sia stato impressionato dall’enormità e dalla qualità del lavoro statistico. E noi siamo fra questi. Inoltre, si potrebbe affermare che la principale qualità del libro di Piketty sia da cercare altrove: è… un libro, ossia quel che gli economisti hanno radicalmente disimparato a fare, ossessionati dall’imperativo di pubblicare che impone loro di moltiplicare gli articoli tecnici e standardizzati, specialistici fino alla perdita di senso, vincolati alle quindici pagine imposte dalle riviste universitarie. Invece, Il Capitale del XXI secolo è la conclusione in mille pagine di uno sforzo perseguito ostinatamente per quindici anni. Infine, l’utilità delle scienze sociali diventa tanto più evidente quando queste si adoperano per nutrire il dibattito politico di fatti solidamente comprovati”. 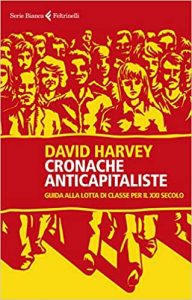 E [7] David Harvey, lo studioso marxista che in questo XXI secolo ha portato contributi numerosi e di grande interesse alla discussione sul presente e sul futuro del capitalismo, in una recensione critica sul «problema centrale nell’argomentazione di Piketty [che]… poggia su una definizione erronea di capitale», elogia una ricerca che documenta dettagliatamente, con una precisione atroce e difficilmente confutabile, l’evoluzione nel corso degli ultimi due secoli della disuguaglianza sociale rispetto sia alla ricchezza che al reddito, con particolare enfasi sul ruolo della ricchezza. Demolisce la largamente diffusa opinione secondo cui il capitalismo del libero mercato sia distributore di ricchezza e rappresenterebbe il grande baluardo per la difesa delle libertà individuali e no. Piketty fa vedere come il capitalismo del libero mercato, in assenza di significativi interventi redistributivi da parte dello Stato, produce oligarchie antidemocratiche. Le notazioni di Lordon e [8] Harvey sono decisamente pertinenti. La gran mole di dati raccolti, l’uso costante di analisi comparativa, ci offrono un quadro di riferimento essenziale per porre su basi concrete la discussione in corso. Credo, però, che non ci si possa limitare a questa considerazione. Il libro non si differenzia soltanto da ciò che «gli economisti hanno radicalmente disimparato a fare» per l’ampiezza e la puntigliosità della ricerca, ma anche per un’impostazione, sia pure qui semplicemente abbozzata, relativa al sapere economico. «Non riesco a concepire l’economia se non come una sotto disciplina delle scienze sociali (…) – scrive Piketty – Non mi piace molto l’espressione “scienza economica”. Mi sembra terribilmente arrogante. (…)
E [7] David Harvey, lo studioso marxista che in questo XXI secolo ha portato contributi numerosi e di grande interesse alla discussione sul presente e sul futuro del capitalismo, in una recensione critica sul «problema centrale nell’argomentazione di Piketty [che]… poggia su una definizione erronea di capitale», elogia una ricerca che documenta dettagliatamente, con una precisione atroce e difficilmente confutabile, l’evoluzione nel corso degli ultimi due secoli della disuguaglianza sociale rispetto sia alla ricchezza che al reddito, con particolare enfasi sul ruolo della ricchezza. Demolisce la largamente diffusa opinione secondo cui il capitalismo del libero mercato sia distributore di ricchezza e rappresenterebbe il grande baluardo per la difesa delle libertà individuali e no. Piketty fa vedere come il capitalismo del libero mercato, in assenza di significativi interventi redistributivi da parte dello Stato, produce oligarchie antidemocratiche. Le notazioni di Lordon e [8] Harvey sono decisamente pertinenti. La gran mole di dati raccolti, l’uso costante di analisi comparativa, ci offrono un quadro di riferimento essenziale per porre su basi concrete la discussione in corso. Credo, però, che non ci si possa limitare a questa considerazione. Il libro non si differenzia soltanto da ciò che «gli economisti hanno radicalmente disimparato a fare» per l’ampiezza e la puntigliosità della ricerca, ma anche per un’impostazione, sia pure qui semplicemente abbozzata, relativa al sapere economico. «Non riesco a concepire l’economia se non come una sotto disciplina delle scienze sociali (…) – scrive Piketty – Non mi piace molto l’espressione “scienza economica”. Mi sembra terribilmente arrogante. (…) 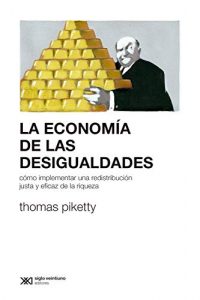 Preferisco di gran lunga l’espressione “economia politica”» Si tenga presente che la sua formazione di economista è avvenuta all’interno di un impianto neoclassico, ed ora, insieme alle scienze sociali come componente essenziali del saper economico, egli riscopre anche la storia. Già di per sé l’esame del meccanismo delle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza seguito in particolare nel corso dei due secoli della seconda modernità correlato con le vicende storiche che influenzano le dinamiche economiche, è un aspetto del tutto inusuale per l’economia ortodossa. Ma questo è solo il punto di partenza per usi più intensi della conoscenza storica. Sei anni dopo l’edizione del Il capitale del XXI secolo, Piketty torna a parlare del problema delle disuguaglianze con un nuovo monumentale volume (Capital et idéologie, Paris, Seuil, 2019) di più di mille pagine. Questa volta la dimensione economica è inserita del tutto in un contesto disciplinare ampio (scienze politiche, antropologia, sociologia) unificate da un impianto storico che ricorre anche a fonti letterarie. Il rapporto tra storia ed economia non è certo quello marxiano, ma i risultati conoscitivi del lavoro sono davvero utili per inserire le pratiche attuali del neoliberismo (Piketty usa la parola néopropriétarisme) in una dinamica di lungo periodo. Si tratta di un’indagine molto ampia su come i propriétaires sono riusciti a rendere naturale la logica inegualitaria della distribuzione dei beni. Logica giustificata da un sistema ideologico e costruita nella società tramite adeguato sistema giuridico. Una ricerca, dunque, centrata su quella che Marx avrebbe chiamato «sovrastruttura», declinata principalmente sul versante dell’ideologia. Una ricerca, come la definisce l’autore, basata sulla «storia dei sistemi di giustificazione e di strutturazione della disuguaglianza sociale».
Preferisco di gran lunga l’espressione “economia politica”» Si tenga presente che la sua formazione di economista è avvenuta all’interno di un impianto neoclassico, ed ora, insieme alle scienze sociali come componente essenziali del saper economico, egli riscopre anche la storia. Già di per sé l’esame del meccanismo delle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza seguito in particolare nel corso dei due secoli della seconda modernità correlato con le vicende storiche che influenzano le dinamiche economiche, è un aspetto del tutto inusuale per l’economia ortodossa. Ma questo è solo il punto di partenza per usi più intensi della conoscenza storica. Sei anni dopo l’edizione del Il capitale del XXI secolo, Piketty torna a parlare del problema delle disuguaglianze con un nuovo monumentale volume (Capital et idéologie, Paris, Seuil, 2019) di più di mille pagine. Questa volta la dimensione economica è inserita del tutto in un contesto disciplinare ampio (scienze politiche, antropologia, sociologia) unificate da un impianto storico che ricorre anche a fonti letterarie. Il rapporto tra storia ed economia non è certo quello marxiano, ma i risultati conoscitivi del lavoro sono davvero utili per inserire le pratiche attuali del neoliberismo (Piketty usa la parola néopropriétarisme) in una dinamica di lungo periodo. Si tratta di un’indagine molto ampia su come i propriétaires sono riusciti a rendere naturale la logica inegualitaria della distribuzione dei beni. Logica giustificata da un sistema ideologico e costruita nella società tramite adeguato sistema giuridico. Una ricerca, dunque, centrata su quella che Marx avrebbe chiamato «sovrastruttura», declinata principalmente sul versante dell’ideologia. Una ricerca, come la definisce l’autore, basata sulla «storia dei sistemi di giustificazione e di strutturazione della disuguaglianza sociale».  Cioè su una storia di ideologie. Si possono certamente avere forti riserve, sulla importanza determinante che, per Piketty, avrebbe l’ideologia nei meccanismi economici della disuguaglianza, ma è indubbio che sui meccanismi dell’ideologia la sua disamina delle varie forme di sacralizzazione della religione economica è particolarmente precisa ed efficace. Il viaggio all’interno di una storia culturale dei rapporti economici porta Piketty a cambiare la prospettiva sul futuro del capitalismo. Se nel libro del 2013 la necessaria lotta alla disuguaglianza restava attuabile nell’orizzonte di un capitalismo dal volto umano, ora questo non viene ritenuto più possibile. «Sulla base delle esperienze analizzate in questo libro – dice Piketty – sono convinto che sia possibile andare oltre l’attuale sistema capitalista e delineare i contorni di un nuovo socialismo partecipativo per il XXI secolo». Abbiamo visto Piketty passare dalla convinzione della possibilità di riformare il capitalismo alla necessità di dépasser (andare oltre). Altri hanno percorso lo stesso itinerario, altri ancora sono arrivati a disperare della possibilità di riforme che modifichino davvero le logiche profonde di una forma di accumulazione che si è consolidata ormai in quarant’anni. L’economista italo-statunitense, [9] Mariana Mazzuccato, ad esempio, nel 2013 pensava alla attuabilità di una ripresa dello Stato innovatore come
Cioè su una storia di ideologie. Si possono certamente avere forti riserve, sulla importanza determinante che, per Piketty, avrebbe l’ideologia nei meccanismi economici della disuguaglianza, ma è indubbio che sui meccanismi dell’ideologia la sua disamina delle varie forme di sacralizzazione della religione economica è particolarmente precisa ed efficace. Il viaggio all’interno di una storia culturale dei rapporti economici porta Piketty a cambiare la prospettiva sul futuro del capitalismo. Se nel libro del 2013 la necessaria lotta alla disuguaglianza restava attuabile nell’orizzonte di un capitalismo dal volto umano, ora questo non viene ritenuto più possibile. «Sulla base delle esperienze analizzate in questo libro – dice Piketty – sono convinto che sia possibile andare oltre l’attuale sistema capitalista e delineare i contorni di un nuovo socialismo partecipativo per il XXI secolo». Abbiamo visto Piketty passare dalla convinzione della possibilità di riformare il capitalismo alla necessità di dépasser (andare oltre). Altri hanno percorso lo stesso itinerario, altri ancora sono arrivati a disperare della possibilità di riforme che modifichino davvero le logiche profonde di una forma di accumulazione che si è consolidata ormai in quarant’anni. L’economista italo-statunitense, [9] Mariana Mazzuccato, ad esempio, nel 2013 pensava alla attuabilità di una ripresa dello Stato innovatore come 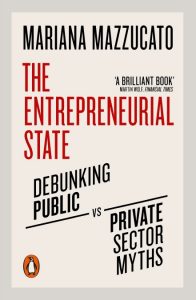 l’attore principale che «si fa carico del rischio nel capitalismo moderno». Nel 2017, pur sostenendo che «il capitalismo occidentale non è irrimediabilmente destinato a fallire», legava tale esito ad una sua modificazione alla «radice». Nel 2019, concordava sul fatto che «il capitalismo è davvero “rotto”» e sulle difficoltà di riaggiustarlo. Come detto non sono pochi gli studiosi di scienze sociali che hanno avuto, stanno avendo, analogo tragitto magari con lievi varianti. Particolarmente indicativo nella nostra ottica mi sembra quello di un economista già citato più sopra, la cui formazione è avvenuta del tutto all’interno del pensiero mainstream e delle istituzioni più alte per la sua applicazione: Joseph Stiglitz. Stiglitz dal 1995 al 1997 è stato Presidente dei consiglieri economici del Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton; dal 1997 al 2000 Senior Vice President e Chief Economist della Banca mondiale. Poi, nel 2001 ha ottenuto il premio Nobel per l’economia. Difficile pensare ad una posizione più centrale negli establishment di produzione della teoria e della pratica economica dominante. Per rendere ancora più chiaro il quadro di partenza, che proprio Bill Clinton abolì la legge Glass-Steagal
l’attore principale che «si fa carico del rischio nel capitalismo moderno». Nel 2017, pur sostenendo che «il capitalismo occidentale non è irrimediabilmente destinato a fallire», legava tale esito ad una sua modificazione alla «radice». Nel 2019, concordava sul fatto che «il capitalismo è davvero “rotto”» e sulle difficoltà di riaggiustarlo. Come detto non sono pochi gli studiosi di scienze sociali che hanno avuto, stanno avendo, analogo tragitto magari con lievi varianti. Particolarmente indicativo nella nostra ottica mi sembra quello di un economista già citato più sopra, la cui formazione è avvenuta del tutto all’interno del pensiero mainstream e delle istituzioni più alte per la sua applicazione: Joseph Stiglitz. Stiglitz dal 1995 al 1997 è stato Presidente dei consiglieri economici del Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton; dal 1997 al 2000 Senior Vice President e Chief Economist della Banca mondiale. Poi, nel 2001 ha ottenuto il premio Nobel per l’economia. Difficile pensare ad una posizione più centrale negli establishment di produzione della teoria e della pratica economica dominante. Per rendere ancora più chiaro il quadro di partenza, che proprio Bill Clinton abolì la legge Glass-Steagal  voluta dal Presidente del New Deal Franklin Delano Roosevelt nel 1933, per porre un argine politico Federale alle scorrerie finanziarie che avevano avuto un ruolo importante nella grande crisi del 1929. La legge prevedeva, infatti, la separazione tra le banche commerciali, le banche di deposito e finanziamento all’attività economica, e le banche d’affari, la cui attività prevalentemente borsistica privilegiava la speculazione sui titoli. Una scelta, quella di Clinton, fondamentale per togliere lacci e laccioli allo sviluppo senza freni del «capitalismo finanziario». Nel 1999 Stiglitz non faceva più parte dell’amministrazione Federale, ma questo era il clima di cui era stato partecipe. Il Nobel del 2001 gli era stato assegnato «per lo studio di imperfezioni e asimmetrie di mercato interpretate come deviazioni dell’equilibrio neoclassico ottimo» di ascendenza paretiana. Il modello per cui è stato premiato Stiglitz «accetta l’idea secondo cui gli alti salari generano disoccupazione e quindi di fatto aderisce alla discussa tesi neoclassica di una relazione inversa tra retribuzioni e assunzioni». Da questo insieme teorico inizia il percorso nel nuovo secolo di Stiglitz. Nella sua posizione operativa in qualità di alto dirigente della Banca mondiale egli si trova confrontato nella tensione tra il modello e il «capitalismo reale».
voluta dal Presidente del New Deal Franklin Delano Roosevelt nel 1933, per porre un argine politico Federale alle scorrerie finanziarie che avevano avuto un ruolo importante nella grande crisi del 1929. La legge prevedeva, infatti, la separazione tra le banche commerciali, le banche di deposito e finanziamento all’attività economica, e le banche d’affari, la cui attività prevalentemente borsistica privilegiava la speculazione sui titoli. Una scelta, quella di Clinton, fondamentale per togliere lacci e laccioli allo sviluppo senza freni del «capitalismo finanziario». Nel 1999 Stiglitz non faceva più parte dell’amministrazione Federale, ma questo era il clima di cui era stato partecipe. Il Nobel del 2001 gli era stato assegnato «per lo studio di imperfezioni e asimmetrie di mercato interpretate come deviazioni dell’equilibrio neoclassico ottimo» di ascendenza paretiana. Il modello per cui è stato premiato Stiglitz «accetta l’idea secondo cui gli alti salari generano disoccupazione e quindi di fatto aderisce alla discussa tesi neoclassica di una relazione inversa tra retribuzioni e assunzioni». Da questo insieme teorico inizia il percorso nel nuovo secolo di Stiglitz. Nella sua posizione operativa in qualità di alto dirigente della Banca mondiale egli si trova confrontato nella tensione tra il modello e il «capitalismo reale». 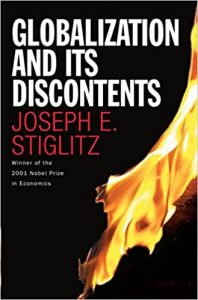 Il libro che scrive nel 2002 è il frutto di questa esperienza. Stiglitz è convinto che la globalizzazione, termine da lui usato per indicare il capitalismo del libero mercato, possa avere effetti positivi. È altresì convinto, nel suo ruolo di dirigente della Banca mondiale, della possibilità di far passare una proposta «equilibrata» nel rapporto con i paesi del sottosviluppo. Sulla base di questa esperienza si rende conto che la «globalizzazione ha portato enormi vantaggi ad alcuni, ma per il modo in cui è stata gestita, tanti milioni di persone non ne hanno tratto alcun beneficio e moltissime altre stanno peggio di prima». Gestire la globalizzazione in maniera diversa è, dunque il problema, ed è un problema politico. «Il cambiamento più sostanziale, necessario, per far funzionare la globalizzazione nel modo dovuto, è un cambiamento del governo di queste istituzioni»: FMI e Banca mondiale. E qui egli fa un’annotazione di estremo interesse, ma che nel libro in questione non approfondisce: «Il problema è che le istituzioni hanno cominciato a riflettere la mentalità di coloro a cui rispondono (il corsivo è mio)». Proprio il fatto di non aver tentato di sciogliere il nodo relativo a «coloro cui rispondono» le istituzioni finiscono per banalizzare il problema politico dell’auspicato cambiamento di governo di quelle istituzioni. Perciò nel libro successivo (2006) Stiglitz, vede segnali incoraggianti nella direzione tesa a
Il libro che scrive nel 2002 è il frutto di questa esperienza. Stiglitz è convinto che la globalizzazione, termine da lui usato per indicare il capitalismo del libero mercato, possa avere effetti positivi. È altresì convinto, nel suo ruolo di dirigente della Banca mondiale, della possibilità di far passare una proposta «equilibrata» nel rapporto con i paesi del sottosviluppo. Sulla base di questa esperienza si rende conto che la «globalizzazione ha portato enormi vantaggi ad alcuni, ma per il modo in cui è stata gestita, tanti milioni di persone non ne hanno tratto alcun beneficio e moltissime altre stanno peggio di prima». Gestire la globalizzazione in maniera diversa è, dunque il problema, ed è un problema politico. «Il cambiamento più sostanziale, necessario, per far funzionare la globalizzazione nel modo dovuto, è un cambiamento del governo di queste istituzioni»: FMI e Banca mondiale. E qui egli fa un’annotazione di estremo interesse, ma che nel libro in questione non approfondisce: «Il problema è che le istituzioni hanno cominciato a riflettere la mentalità di coloro a cui rispondono (il corsivo è mio)». Proprio il fatto di non aver tentato di sciogliere il nodo relativo a «coloro cui rispondono» le istituzioni finiscono per banalizzare il problema politico dell’auspicato cambiamento di governo di quelle istituzioni. Perciò nel libro successivo (2006) Stiglitz, vede segnali incoraggianti nella direzione tesa a  «salvare la globalizzazione dai suoi sostenitori». Commentando i risultati dell’incontro annuale a Davos del Forum Economico Mondiale, incontro tra esponenti internazionali di primo piano dell’ambito economico, politico, scientifico e sociale, egli scrive: «Si è parlato di riforme (…) Il dibattito sulla globalizzazione è passato da una presa di coscienza generalizzata che non tutto era andato nel verso giusto (…) a una analisi più approfondita che collega politiche specifiche a specifici fallimenti. (…) Il vento del cambiamento ha già cominciato a soffiare. Ci saranno riforme (…) Finalmente la povertà preoccupa tutti». Tanto più che «i mercati finanziari sono notevolmente migliorati». La Grande crisi, appena dietro l’angolo, avrebbe dimostrato la fragile base di tali speranze. Di questo Stiglitz prende atto nel terzo dei tre libri dedicati alla globalizzazione capitalistica in un arco temporale di 11 anni. Non rinuncia alla possibilità di una civilizzazione del capitalismo, ma non vede elementi che si muovono verso quella direzione in una realtà dove «esistono forze di mercato che ci trascinano in senso contrario». Ci fu un momento, scrive Stiglitz, in cui si «ebbe l’audacia di sperare: la tendenza in atto da più di un quarto di secolo avrebbe potuto essere invertita. Invece è peggiorata. Oggi quella speranza va vacillando».
«salvare la globalizzazione dai suoi sostenitori». Commentando i risultati dell’incontro annuale a Davos del Forum Economico Mondiale, incontro tra esponenti internazionali di primo piano dell’ambito economico, politico, scientifico e sociale, egli scrive: «Si è parlato di riforme (…) Il dibattito sulla globalizzazione è passato da una presa di coscienza generalizzata che non tutto era andato nel verso giusto (…) a una analisi più approfondita che collega politiche specifiche a specifici fallimenti. (…) Il vento del cambiamento ha già cominciato a soffiare. Ci saranno riforme (…) Finalmente la povertà preoccupa tutti». Tanto più che «i mercati finanziari sono notevolmente migliorati». La Grande crisi, appena dietro l’angolo, avrebbe dimostrato la fragile base di tali speranze. Di questo Stiglitz prende atto nel terzo dei tre libri dedicati alla globalizzazione capitalistica in un arco temporale di 11 anni. Non rinuncia alla possibilità di una civilizzazione del capitalismo, ma non vede elementi che si muovono verso quella direzione in una realtà dove «esistono forze di mercato che ci trascinano in senso contrario». Ci fu un momento, scrive Stiglitz, in cui si «ebbe l’audacia di sperare: la tendenza in atto da più di un quarto di secolo avrebbe potuto essere invertita. Invece è peggiorata. Oggi quella speranza va vacillando».  Quindi nessun «capitalismo dal volto umano» all’orizzonte, ma ben saldo, in questa nostra modernità, il «capitalismo reale».
Quindi nessun «capitalismo dal volto umano» all’orizzonte, ma ben saldo, in questa nostra modernità, il «capitalismo reale».
(continua)
Se hai domande o riflessioni da fare ti invito a lasciare un commento a questo post: sarò felice di risponderti oppure prendi appuntamento per una sessione di coaching gratuita
22
DIC
DIC
0
