
Una Direzione del partito durata ben quasi dieci ore all’insegna del «chi siamo cosa vogliamo» e delle ragioni della sconfitta, ma ad ascoltar bene l’orologio della discussione puntava più a discutere sulla sconfitta di cinque anni fa (2018)… che non su quella del 25 settembre di quest’anno. L’attenuante è che il necessario livello della discussione è di per se stesso improbo. Tant’è che dalla Direzione dell’altro ieri il Partito democratico esce ancora senza un’idea chiara su come risalire la china dopo una sconfitta politica senza precedenti. Visto che è accompagnata dall’ingresso dei post-fascisti a Palazzo Chigi. Quindi una sconfitta secca e amara e sicuramente pesante.  Tale da cambiare addirittura i connotati civili dell’intero Paese. Insieme alla sua geografia politica. Infatti, le elezioni del 25 settembre archiviano l’antifascismo come memoria costituente e come collante etico della Repubblica. Allo stesso tempo, diventa più vulnerabile il corpo dei diritti civili, minacciando la libertà delle donne e corrodendo il sentimento della laicità dello Stato. L’Italia così finisce in una terra incognita, lungamente seminata dal qualunquismo, dal populismo sovranista, dal radicalismo identitario. Deve prendere atto che il Pd è fuggito dalla questione sociale e ha lasciato morire tutte le sue utopie… e che questo ha sicuramente contribuito a far perdere l’identità e il senso di se stesso al partito democratico, oltre che ogni fascino della sua storica collocazione nella Sinistra. Nella discussione in corso si dice giustamente che la sconfitta viene da lontano. Ma anche la vittoria della destra viene da lontano, anzi viene dal profondo, dalle viscere di una nazione di cui il fascismo è stato parte viva dell’autobiografia complessiva della stessa.
Tale da cambiare addirittura i connotati civili dell’intero Paese. Insieme alla sua geografia politica. Infatti, le elezioni del 25 settembre archiviano l’antifascismo come memoria costituente e come collante etico della Repubblica. Allo stesso tempo, diventa più vulnerabile il corpo dei diritti civili, minacciando la libertà delle donne e corrodendo il sentimento della laicità dello Stato. L’Italia così finisce in una terra incognita, lungamente seminata dal qualunquismo, dal populismo sovranista, dal radicalismo identitario. Deve prendere atto che il Pd è fuggito dalla questione sociale e ha lasciato morire tutte le sue utopie… e che questo ha sicuramente contribuito a far perdere l’identità e il senso di se stesso al partito democratico, oltre che ogni fascino della sua storica collocazione nella Sinistra. Nella discussione in corso si dice giustamente che la sconfitta viene da lontano. Ma anche la vittoria della destra viene da lontano, anzi viene dal profondo, dalle viscere di una nazione di cui il fascismo è stato parte viva dell’autobiografia complessiva della stessa.  Viene dalla rimozione della storia, dal degrado delle culture politiche, dalla “dittatura del presente” che ha ridotto i partiti in gestori delle emergenze piuttosto che in architetti del futuro. Viene dal disperdersi di una memoria collettiva delegata ormai solo ai musei e alle celebrazioni. Viene dal deserto della partecipazione, che è stato osservato come fosse un fenomeno meteorologico che non come un fatto politico di prim’ordine. E come se tutto ciò non fosse vero, in modo autoconsolatorio, Enrico Letta ha detto: «che in fondo la sconfitta non è stata catastrofica».
Viene dalla rimozione della storia, dal degrado delle culture politiche, dalla “dittatura del presente” che ha ridotto i partiti in gestori delle emergenze piuttosto che in architetti del futuro. Viene dal disperdersi di una memoria collettiva delegata ormai solo ai musei e alle celebrazioni. Viene dal deserto della partecipazione, che è stato osservato come fosse un fenomeno meteorologico che non come un fatto politico di prim’ordine. E come se tutto ciò non fosse vero, in modo autoconsolatorio, Enrico Letta ha detto: «che in fondo la sconfitta non è stata catastrofica».  È stata una Direzione all’insegna del «chi siamo cosa vogliamo», quasi dieci ore, con decine di interventi, giovani e meno giovani, uomini e donne, anziani dirigenti e nuove promesse si sono alternati per dire più o meno le stesse cose, si, c’è stata molta autocritica ma nessuno si è messo direttamente in discussione proprio nascondendosi dietro al fatto che la lettura del voto non è stata considerata una catastrofe: «tranne Fratelli di Italia, gli altri sono andati tutti peggio di noi».
È stata una Direzione all’insegna del «chi siamo cosa vogliamo», quasi dieci ore, con decine di interventi, giovani e meno giovani, uomini e donne, anziani dirigenti e nuove promesse si sono alternati per dire più o meno le stesse cose, si, c’è stata molta autocritica ma nessuno si è messo direttamente in discussione proprio nascondendosi dietro al fatto che la lettura del voto non è stata considerata una catastrofe: «tranne Fratelli di Italia, gli altri sono andati tutti peggio di noi».  Ma, allora perché fare un congresso? Perché annunciare le dimissioni da Segretario? Nel Pd nessuno si dimette, lo fa solo Enrico Letta e non lo fa subito anche se è certo che la sua leadership finisce qui. Si assume il ruolo di “traghettatore”. Svolgendo una relazione “aperta” che ha fissato con certezza solo il congresso a marzo contro chi voleva tirarla in lungo
Ma, allora perché fare un congresso? Perché annunciare le dimissioni da Segretario? Nel Pd nessuno si dimette, lo fa solo Enrico Letta e non lo fa subito anche se è certo che la sua leadership finisce qui. Si assume il ruolo di “traghettatore”. Svolgendo una relazione “aperta” che ha fissato con certezza solo il congresso a marzo contro chi voleva tirarla in lungo  (ci ha provato ancora Luigi Zanda). Mentre il fantasma di
(ci ha provato ancora Luigi Zanda). Mentre il fantasma di  Stefano Bonaccini non è stato evocato (lui se n’è andato via presto), come se tutti fossero stati d’accordo nell’eludere la questione della sua leadership, tranne una polemica Paola De Micheli che ha confermato la sua candidatura. D’altra parte il ‘refrain’ che è risuonato più di tutti è che: «il problema non è di nomi ma d’identità». Come se nel XXI secolo le due cose fossero veramente separabili.
Stefano Bonaccini non è stato evocato (lui se n’è andato via presto), come se tutti fossero stati d’accordo nell’eludere la questione della sua leadership, tranne una polemica Paola De Micheli che ha confermato la sua candidatura. D’altra parte il ‘refrain’ che è risuonato più di tutti è che: «il problema non è di nomi ma d’identità». Come se nel XXI secolo le due cose fossero veramente separabili. Molto successo ha avuto anche il ripudio della proposta di scioglimento del partito (da quelle parti dove disistimano, no! Odiano Calenda e Renzi che lo scioglimento suggeriscono), c’è una sola verità: il partito è dominato da una schizofrenia di fondo, che poi è “il vero” problema del Partito democratico: da una parte l’orgogliosa rivendicazione della propria esistenza, dall’altra un’insistita autoflagellazione. «Congresso costituente», l’ha definito Letta e poi
Molto successo ha avuto anche il ripudio della proposta di scioglimento del partito (da quelle parti dove disistimano, no! Odiano Calenda e Renzi che lo scioglimento suggeriscono), c’è una sola verità: il partito è dominato da una schizofrenia di fondo, che poi è “il vero” problema del Partito democratico: da una parte l’orgogliosa rivendicazione della propria esistenza, dall’altra un’insistita autoflagellazione. «Congresso costituente», l’ha definito Letta e poi tutti quanti a sottolineare, con annessa rilevante ma al tempo stesso sfuggente autocritica sulle correnti, sul governismo, sulla lontananza dai più deboli, sfuggente perché non accompagnata dai rimedi possibili, da indicazioni sul “che fare” al di là della scontata volontà di un’opposizione dura al nascente governo della destra. Ci si è insomma fatti coraggio l’un l’altro in un consesso in cui non mancano odii e dissapori (pure la polemica di Goffredo Bettini sull’ordine degli interventi deciso
tutti quanti a sottolineare, con annessa rilevante ma al tempo stesso sfuggente autocritica sulle correnti, sul governismo, sulla lontananza dai più deboli, sfuggente perché non accompagnata dai rimedi possibili, da indicazioni sul “che fare” al di là della scontata volontà di un’opposizione dura al nascente governo della destra. Ci si è insomma fatti coraggio l’un l’altro in un consesso in cui non mancano odii e dissapori (pure la polemica di Goffredo Bettini sull’ordine degli interventi deciso  dalla presidente Valentina Cuppi), dove è tornato di moda persino l’occhettiano “zoccolo duro”, si è disegnato un insieme di problemi reali ma senza individuare un punto forte e unitario. Ci si è avvicinato Matteo Orfini quando ha detto che «una parte del gruppo dirigente non crede più alle ambizioni per le quali abbiamo fatto il Pd», ormai vissuto come «difensore dello status quo», che è poi la ragione per cui «nessuno ci ha votato con felicità». Parecchia autoflagellazione su quello che è diventata la vita reale del partito e contro il correntismo.
dalla presidente Valentina Cuppi), dove è tornato di moda persino l’occhettiano “zoccolo duro”, si è disegnato un insieme di problemi reali ma senza individuare un punto forte e unitario. Ci si è avvicinato Matteo Orfini quando ha detto che «una parte del gruppo dirigente non crede più alle ambizioni per le quali abbiamo fatto il Pd», ormai vissuto come «difensore dello status quo», che è poi la ragione per cui «nessuno ci ha votato con felicità». Parecchia autoflagellazione su quello che è diventata la vita reale del partito e contro il correntismo.  Il vicesegretario Peppe Provenzano ha alluso persino a «dossieraggi». Le donne del Pd sono infuriate per la loro poca presenza nelle liste (ma la colpa è anche loro). Ogni tanto (ma senza affondare) in qualche intervento, sono state lanciate frecciatine sul passato che non passa mai, quello di Renzi. E su questo aspetto, mi sia consentito una sottolineatura tutta politica che resta ancora centrale per la discussione in corso: perché è già dal 2018, che di fatto si è aperta e prospettata l’attuale disfatta.
Il vicesegretario Peppe Provenzano ha alluso persino a «dossieraggi». Le donne del Pd sono infuriate per la loro poca presenza nelle liste (ma la colpa è anche loro). Ogni tanto (ma senza affondare) in qualche intervento, sono state lanciate frecciatine sul passato che non passa mai, quello di Renzi. E su questo aspetto, mi sia consentito una sottolineatura tutta politica che resta ancora centrale per la discussione in corso: perché è già dal 2018, che di fatto si è aperta e prospettata l’attuale disfatta. 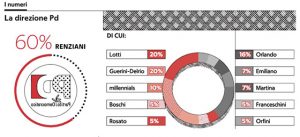 E data la ancora numerosa presenza di ex renziani nel partito, sulle colpe del renzismo rispetto alla perdita d’identità del partito in nome di una presenza costante al governo del Paese, si continua a tergiversare. Infatti, chi se non
E data la ancora numerosa presenza di ex renziani nel partito, sulle colpe del renzismo rispetto alla perdita d’identità del partito in nome di una presenza costante al governo del Paese, si continua a tergiversare. Infatti, chi se non  Matteo Renzi, in questi ultimi anni ha fatto suo il mantra (sia quando era all’interno che poi dall’esterno del Pd, una volta uscito fondando Italia Viva) della presenza e della stabilità di Governo? Proprio a partire dal Conte 2 per poi proseguire con il Governo Draghi… cos’è, scarsa memoria o il solito “politicamente scorretto?”
Matteo Renzi, in questi ultimi anni ha fatto suo il mantra (sia quando era all’interno che poi dall’esterno del Pd, una volta uscito fondando Italia Viva) della presenza e della stabilità di Governo? Proprio a partire dal Conte 2 per poi proseguire con il Governo Draghi… cos’è, scarsa memoria o il solito “politicamente scorretto?”  A Andrea Orlando va dato atto di essere entrato (unico) nel merito, in sostanza ha proposto la questione della «critica al mercato e al capitalismo senza regole» incarnando così il possibile candidato anti-Bonaccini e tracciando i contorni di una prospettiva “neo-socialista”: offrendo così almeno un punto di chiarezza che insieme a un certo spostamento “pacifista” dà la sensazione di un possibile spostamento a sinistra del partito.
A Andrea Orlando va dato atto di essere entrato (unico) nel merito, in sostanza ha proposto la questione della «critica al mercato e al capitalismo senza regole» incarnando così il possibile candidato anti-Bonaccini e tracciando i contorni di una prospettiva “neo-socialista”: offrendo così almeno un punto di chiarezza che insieme a un certo spostamento “pacifista” dà la sensazione di un possibile spostamento a sinistra del partito.  Diciamoci la verità, la parola “sinistra” ha ormai un suono straniero in tanta parte della periferia sociale d’Italia, non anima più la passione operaia, non profuma più di popolo, non evoca più alcun tipo di rivoluzione, non è più la bandiera che viene portata nel cuore. Anzi, talvolta quella parola ‘puzza di potere’, di compromissione, di resa alle ragioni e soprattutto ai torti, dell’avversario. La soggezione al paradigma mercatista, la fuga scomposta dalla “questione sociale”, la scomparsa di un agire collettivo nutrito dalla partecipazione militante, la morte delle utopie. Chi o cosa, se non il liberismo ha bruciato la tavola dei valori del Pd? Affidandogli un ruolo di controcanto retorico e politicamente innocuo sulla stabilità di Governo. Il riformismo dei post-comunisti e quello dei liberal-laburisti alla fine si è arreso dinanzi allo scandalo della povertà e della diseguaglianza, ha finto che il conflitto sociale fosse un anacronismo, ha dismesso come una giacca strappata quel pensiero critico che invocava e invoca la rivolta contro un sistema di ricchezza istituzionalmente protetta e di povertà culturalmente colpevolizzata. Dice
Diciamoci la verità, la parola “sinistra” ha ormai un suono straniero in tanta parte della periferia sociale d’Italia, non anima più la passione operaia, non profuma più di popolo, non evoca più alcun tipo di rivoluzione, non è più la bandiera che viene portata nel cuore. Anzi, talvolta quella parola ‘puzza di potere’, di compromissione, di resa alle ragioni e soprattutto ai torti, dell’avversario. La soggezione al paradigma mercatista, la fuga scomposta dalla “questione sociale”, la scomparsa di un agire collettivo nutrito dalla partecipazione militante, la morte delle utopie. Chi o cosa, se non il liberismo ha bruciato la tavola dei valori del Pd? Affidandogli un ruolo di controcanto retorico e politicamente innocuo sulla stabilità di Governo. Il riformismo dei post-comunisti e quello dei liberal-laburisti alla fine si è arreso dinanzi allo scandalo della povertà e della diseguaglianza, ha finto che il conflitto sociale fosse un anacronismo, ha dismesso come una giacca strappata quel pensiero critico che invocava e invoca la rivolta contro un sistema di ricchezza istituzionalmente protetta e di povertà culturalmente colpevolizzata. Dice  Flavio Briatore imperterrito cantore del ricco è bello – “non ho mai visto un povero creare posti di lavoro… danno solo fastidio”. Che Farabutto!!! Chiediamoci perché per il Pd non è ancora tempo di aprire una riflessione sul paradosso di quel “riformismo delle contro-riforme” (es. il Job Act) che ha di fatto ibernato la Sinistra, rendendola complice delle politiche di precarizzazione del mercato del lavoro, di aziendalizzazione del Welfare e della Scuola, di privatizzazione dei beni pubblici?
Flavio Briatore imperterrito cantore del ricco è bello – “non ho mai visto un povero creare posti di lavoro… danno solo fastidio”. Che Farabutto!!! Chiediamoci perché per il Pd non è ancora tempo di aprire una riflessione sul paradosso di quel “riformismo delle contro-riforme” (es. il Job Act) che ha di fatto ibernato la Sinistra, rendendola complice delle politiche di precarizzazione del mercato del lavoro, di aziendalizzazione del Welfare e della Scuola, di privatizzazione dei beni pubblici?  Come se il riformismo fosse un’idea acritica della modernità, un mero codice di adattamento e di soggezione alla ‘signoria del mercato’? Perché la sinistra di governo non è stata il partito della ribellione contro le “strutture di peccato” del vigente modello sociale. Non è stata un’idea di movimento e di trasformazione? È stata piuttosto il pilastro immarcescibile della stabilità di governo, sposando un europeismo di maniera e un atlantismo acritico: e purtroppo dalla teoria della governabilità alle pratiche deteriori del governismo il passo è stato breve. La sinistra di governo doveva essere invece fautrice di un progetto di Società più equa e giusta. Così non è stato! Tutto il resto è stato riassunto in una discussione affabulatoria, dalla quale è stata rimossa con la solita solfa che “il problema non è questo”, ma è quello delle alleanze (non fatte e/o fatte in modo sbagliato) e che quindi questo tema non è più solo un giochino elettorale ma è una scelta di campo precisa tra Mélenchon e Macron (sintesi che non piace a
Come se il riformismo fosse un’idea acritica della modernità, un mero codice di adattamento e di soggezione alla ‘signoria del mercato’? Perché la sinistra di governo non è stata il partito della ribellione contro le “strutture di peccato” del vigente modello sociale. Non è stata un’idea di movimento e di trasformazione? È stata piuttosto il pilastro immarcescibile della stabilità di governo, sposando un europeismo di maniera e un atlantismo acritico: e purtroppo dalla teoria della governabilità alle pratiche deteriori del governismo il passo è stato breve. La sinistra di governo doveva essere invece fautrice di un progetto di Società più equa e giusta. Così non è stato! Tutto il resto è stato riassunto in una discussione affabulatoria, dalla quale è stata rimossa con la solita solfa che “il problema non è questo”, ma è quello delle alleanze (non fatte e/o fatte in modo sbagliato) e che quindi questo tema non è più solo un giochino elettorale ma è una scelta di campo precisa tra Mélenchon e Macron (sintesi che non piace a  Gianni Cuperlo, viziato dal guardare sempre oltre i confini del partito e abituato guardare l’ampia articolazione di una Società complessa),
Gianni Cuperlo, viziato dal guardare sempre oltre i confini del partito e abituato guardare l’ampia articolazione di una Società complessa),  cioè tra un partito testimone del malessere sociale o forza riformatrice di governo, e la vaghezza utopica della famosa “identità” ovvero di un’anima. E proprio sul governo c’è stata la sorpresa: la critica del governismo è diventata autocritica per essere stati lunghi anni al governo, senza essere passati per il voto, come se alla fine la scelta di partecipare al Conte 2 fosse stata dettata dagli dèi e non fosse stata una spinta di Renzi contro
cioè tra un partito testimone del malessere sociale o forza riformatrice di governo, e la vaghezza utopica della famosa “identità” ovvero di un’anima. E proprio sul governo c’è stata la sorpresa: la critica del governismo è diventata autocritica per essere stati lunghi anni al governo, senza essere passati per il voto, come se alla fine la scelta di partecipare al Conte 2 fosse stata dettata dagli dèi e non fosse stata una spinta di Renzi contro  Zingaretti che il Conte 2 non voleva. Tutto ciò rischia alla fine, di essere una lettura giustificatoria della sconfitta oltre che, la premessa per l’abbandono definitivo di una aspirazione al governo, che è esattamente la ragione di fondo che a suo tempo, a portato alla nascita del Partito democratico. Enrico Letta ha annunciato alla fine che quando il governo Meloni cadrà – ma lo ha fatto fuori tempo: «chiederemo elezioni anticipate», il che suona sicuramente bene, ma sinceramente come si fa a dirlo oggi? Alla fine, tutti tranne uno e due astenuti, sono stati d’accordo sulla relazione del Segretario: nel fumo delle parole e nell’ansia di un futuro incerto si andrà quindi ad un congresso ça va sans dire “aperto”, qualunque cosa ciò significhi e poi alla sfida delle primarie.
Zingaretti che il Conte 2 non voleva. Tutto ciò rischia alla fine, di essere una lettura giustificatoria della sconfitta oltre che, la premessa per l’abbandono definitivo di una aspirazione al governo, che è esattamente la ragione di fondo che a suo tempo, a portato alla nascita del Partito democratico. Enrico Letta ha annunciato alla fine che quando il governo Meloni cadrà – ma lo ha fatto fuori tempo: «chiederemo elezioni anticipate», il che suona sicuramente bene, ma sinceramente come si fa a dirlo oggi? Alla fine, tutti tranne uno e due astenuti, sono stati d’accordo sulla relazione del Segretario: nel fumo delle parole e nell’ansia di un futuro incerto si andrà quindi ad un congresso ça va sans dire “aperto”, qualunque cosa ciò significhi e poi alla sfida delle primarie.  Francamente mi sembra che ancora una volta si rischi di proseguire una corsa: “a fari spenti nella notte per vedere se è poi tanto difficile morire”.
Francamente mi sembra che ancora una volta si rischi di proseguire una corsa: “a fari spenti nella notte per vedere se è poi tanto difficile morire”.
E’ sempre tempo di Coaching!
Se hai domande o riflessioni da fare ti invito a lasciare un commento a questo post: sarò felice di risponderti oppure prendi appuntamento per una sessione di coaching gratuito
8
OTT
OTT
0
